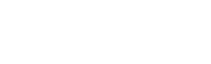Ho vissuto al Vomero 15 anni della mia vita, i primi. Lì ho fatto la scuola dell’obbligo tra il Robert Owen, il Notre Dame e il Maria Ausiliatrice. Il quartiere che mio padre ha odiato per il suo traffico insopportabile tanto da costringere la famiglia a un osteggiato trasferimento nella verde Posillipo, è oggi meta di ritorno di tante famiglie. Nell’isola pedonale di via Scarlatti e intorno a Piazza Vanvitelli anche nel week end, dove un tempo scorrazzavano auto puzzolenti e rumorose è un brulicare di carrozzini con bambini. Palloni gonfi d’elio colorano l’aria. Cresce il desiderio di avere una casa in questa oasi di pace della città meno baby friendly d’Italia. Mentre a via Duomo è lotta serrata in questi giorni contro il senso unico o eventualmente (magari!) la chiusura al traffico completa della strada, al Vomero, quartiere collinare ricordato da più di un italoamericano attraverso libri e nomi di locali, si apprezza oggi quella che fu un’iniziativa contrastata: l’area pedonale. Giù, al centro, prevale, sembra, una concezione opposta (forse malata) a quella normale di quelli che sono i requisiti per fare del buon business con il commercio. Per qualche strano motivo si pensa che mettere a suo agio l’acquirente tenendogli lontane fonte di stress come le auto e i motorini non stimoli la sua propensione all’acquisto? In realtà è la propensione al cambiamento il punto. Ogni dispositivo di traffico nuovo, o innovazione in genere, genera preoccupazione visto che si vive sempre al limite, sospesi a un filo sottile che è sempre lì lì per spezzarsi. La prospettiva della caduta libera nel baratro con cui si convive quotidianamente paralizza. E’ onestamente difficile, ammetto, pensare in grande se è sulle piccole cose che si gioca la partita della sopravvivenza. E dalla fiducia nell’amministrazione, ai minimi termini, non si trae alcuno stimolo a pensare al bene comune.
Si arriva cosi’ a desiderare al fuga dalla storia, a pensare che vivere al Vomero sia il massimo della vita. Il processo è quello che induce a costruire nuove città a ridosso dei centri antichi solo perchè offrono posto per l’auto e la vita si svolge senza scalinate e salite, orizzontale. E’ una perdita netta di cultura, ma forse inevitabile fino a che i centri storici non mostreranno i propri pregi.
Quello del quartiere Vomero è un caso esemplificativo. Non ha la ricchezza artistica del centro storico, nè la storia ovviamente, ma chi può negare che si possa anche chiudere un occhio su un palazzo brutto se se ne guadagna in salute e se i tuoi figli possono correre qualche metro senza finire sotto un motorino che corre contromano? Il Vomero come il quartiere Posillipo hanno una caratteristica comune: la capacità di contenere la naturale propensione al disordine dei napoletani. Non c’è cittadino di serie A o di serie B, ma solo quello che si è dimenticato di esserlo. E nel centro storico, o nella periferia, per quanto ci sipossa sf0rzare di ricordarselo, sin dalle prime poppate del latte materno, ti lavano via la voglia di tenere alta la bandiera della città e quella del Paese. Tra le pareti scrostate degli edifici, i cumuli di spazzatura, gli escrementi di animali, si impara a diventare quei napoletani che Benedetto Croce definì diavoli. E’ un Paradiso difficile e poco accogliente quello della città, e il Vomero, sebbene non abbia la nobiltà del centro storico, sebbene rappresenti più i fasti di una borghesia arricchita dal commercio che quelli del passato glorioso di Parthenope e del suo Golfo, è sempre un pò meno infernale dell’Inferno che si sviluppa sotto la sua collina.
Una riflessione suggerita dalla mia visita alla pizzeria Acunzo di Via Cimarosa e alla Friggitoria Vomero che mi ha pasciuto (qui: http://campaniachevai.blogspot.com/2010/10/monicotterate-le-migliori-pizze-di.html).