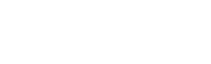Quando a giugno ho prenotato il mio biglietto aereo per il Salone del Gusto, non avrei immaginato che la presentazione della Guida Slow Food fosse un paio di giorni prima dell’inizio della manifestazione. E’ accaduto allora che, impossibilitata a cambiar volo, prenotazioni, impegni, sia rimasta a Napoli mentre a Torino si svolge l’appuntamento che ho atteso per un anno.
Non mancherò certo la visita alla Sala dove sono in degustazione tutti i vini della Guida quando il 22 arriverò a Torino, ma confesso che non so che avrei dato per essere lì.
E’ stata un’esperienza interessante e arricchente che mi ha dato modo di toccare con mano, ancora una volta di più, come l’agricoltura offra ancora degli esempi di integrità. Parlo di rigore e di umanità. In qualche modo, infatti, la passione possiamo anche darla per scontata, visto che lavorare la terra di questi tempi non è cosa in cui cimentarsi se non la si ama. Precipitano i prezzi che ripagano il lavoro e i costi tolgono il respiro. Si è appena conclusa la vendemmia in molte zone d’Italia e i segnali sono comunque che l’agricoltura ha bisogno di essere sostenuta.
Quello che più mi ha emozionato quest’anno, nelle degustazioni fatte, è stato l’Aglianico del Vulture. Il territorio ha grandissime potenzialità: è bello, ricco di tradizioni, facile da viaggiare. Ma non tutti lo sanno, al punto che qualcuno si rallegra che Basilicata Coast to Coast, un film di quest’anno, la abbia fatta conoscere.
Ho visitato lì alcune cantine, tutte di grandissimo livello. Nella Cantina dei Fucci ho trovato un campione di sapidità ed eleganza eccelsa. Ho visto con i miei occhi la sabbia lavica, quella che molti vantano, coprire gli strati sottostanti. Ho visto le stratificazioni della lava. Li cito solo per dire che non si può più parlare di vino senza aver passato una giornata, x giornate, con i piedi sulla terra da dove vengono. La disposizione alla confessione, al raccontarsi, di una persona colta nel suo ambiente più naturale, nel suo humus, fa si che si percepiscano delle cose che non trapelerebbero mai quando è in vetrina in una fiera, quando ti manda dei campioni o ti guida in una degustazione.
Vedere, toccare e ascoltare, diventa questione di rispetto per il lavoro altrui ma soprattutto per il proprio.
Il Vulture paesaggisticamente mostra molto di più del vino di quanto non facciano zone molto vocate, come l’Irpinia. La conformazione dei due areali è molto diversa. Questo è il motivo.
L’aglianico in Irpinia è più sparpagliato, gli appezzamenti più frazionati. Gli spazi più angusti. L’Irpinia si mostra come una regione del vino del tutto peculiare nel Sud: più di montagna, con un microclima poco accogliente, forse, perfino per l’uomo, ma che alla vite, stressata, fa un gran bene. I risultati in bottiglia rispecchiano questo: gli aspetti duri del vino, quelli sono la stoffa buona su cui solo il tempo ricama riccamente, escono fuori. Umanamente anche il tipo “irpino” ha un suo perchè se si conosce meglio il territorio. Allora non vi sorprenderà la scarsa attenzione per gli appuntamenti del vino rispetto ai quali, naturalmente, la presenza del produttore è valutata altrove come indice di impegno. O la richiesta inesaudita di informazioni o il ritardo nell’invio di campioni. L’irpino è lupo, solitario.
Vulture e Irpinia, oltre al loro vitigno principe, vitigno che non teme (usando un parallelo abusato) la concorrenza del decantato Nebbiolo, hanno in comune la componente vulcanica. Il primo di antichissima formazione vulcanica, e, l’altro, di diretta influenza vulcanica per i depositi delle impressionanti eruzioni del Vesuvio.
Aglianico, aglianico e aglianico.
Confesso il mio debole per questo vitigno del Sud, confesso quello per i vini colorati, dalla trama fitta. Anche se non sono di moda, sembra, per un certo ritorno ai vini trasparenti. Adesso è il momento dei Gaglioppo e dei Nerello, mentre quello dei Nebbiolo da quando è inziato non è finito mai. Ma se il colore alcuni vitigni ce l’hanno, ben venga. Mi piace lavorare senza pregiudi: il colore c’è dove ci deve stare, cosi’ come il tannino, l’alcol e tutto il resto. Mi piace trovare conferme alle mie idee ma anche ricredermi.
In un tempo in cui il consumatore si fa, per fortuna, più raffinato, che tutto il Mondo del vino è stato scoperto e sviscerato, che molti produttori hanno imparato ad arte come porgersi nei confronti della stampa e della critica, la prova del nove è più che mai in campagna. Occorre verificare e offrire un racconto più vero del vino.
Questo ha fatto Slow Food e io sono felice di essere stata della partita. Credo che la Guida, i suoi curatori Fabio Giavedoni e Giancarlo Gariglio, Slow Food tutta, abbiano fatto quello cnhe si proponevano. Come ogni lavoro, anche questo è da migliorare. Ma la dedizione c’è stata tutta e il segnale è stato dato. Complimenti a tutto il gruppo.
ps: se volete capire lo spirito di Slow Food non mancate a Terra Madre e alla sua inaugurazione (sotto le mie foto dell’ultima edizione: 2008)